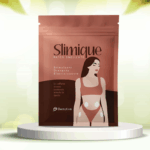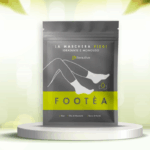Quando inspiriamo, insieme all’aria entrano nel naso molecole odorose, ovvero minuscole particelle volatili che derivano da tutto ciò che ci circonda: cibo, piante, esseri viventi, oggetti. Queste molecole viaggiano sospinte dal respiro e raggiungono una zona molto raffinata situata nella parte superiore della cavità nasale, chiamata epitelio olfattivo. Questa regione è costellata di migliaia di cellule specializzate, i neuroni olfattivi, che rappresentano la nostra porta di accesso al mondo degli odori.
Il processo biologico della percezione olfattiva
I neuroni olfattivi sono immersi in uno strato di muco; qui le molecole odorose si sciolgono e interagiscono con degli speciali recettori, proteine capaci di riconoscere strutture chimiche molto specifiche. L’interazione mima il principio della “chiave-serratura”: solo certe molecole si adattano perfettamente ad alcuni recettori, attivandoli e avviando una cascata di segnali nervosi. Sorprendentemente, nel nostro epitelio olfattivo esistono centinaia di tipi diversi di recettori, ognuno specializzato nel captare determinate famiglie di composti chimici.
Le informazioni raccolte dai recettori vengono trasmesse da impulsi elettrici che risalgono attraverso i neuroni, attraversano la base del cranio e raggiungono il bulbo olfattivo, la prima centrale di smistamento delle informazioni olfattive. Qui avviene un’affascinante elaborazione: i segnali provenienti da migliaia di neuroni che esprimono lo stesso tipo di recettore convergono in una specifica struttura denominata glomerulo olfattivo. Il bulbo inizia a “decodificare” la firma chimica delle molecole e invia il risultato a regioni del cervello cruciali per l’elaborazione delle emozioni e della memoria, come il sistema limbico e l’ippocampo.
L’olfatto e le sue funzioni nella vita quotidiana
La percezione degli odori non si limita al riconoscimento di profumi o aromi piacevoli. È un senso fondamentale per la sicurezza—pensiamo alla capacità di avvertire il fumo di un incendio o la presenza di cibo avariato—ma svolge anche un ruolo centrale nel comportamento sociale e nella comunicazione non verbale. Ricordi, emozioni e associazioni sono profondamente influenzati da ciò che annusiamo: un singolo odore può evocare, improvvisamente e con grande intensità, immagini e sentimenti legati a eventi passati, grazie ai circuiti che collegano i centri olfattivi con la memoria e le emozioni.
Nel regno animale, molti comportamenti sociali sono regolati dalla percezione di odori specifici, come i feromoni, sostanze chimiche utilizzate per trasmettere informazioni tra individui della stessa specie. Anche negli esseri umani questi segnali giocano un ruolo importante nella scelta del partner e nella percezione del benessere psicofisico. L’olfatto contribuisce infine all’esperienza del gusto: la maggior parte dei sapori che percepiamo è in realtà dovuta alle molecole odorose che raggiungono l’epitelio olfattivo durante la masticazione.
Le basi chimiche della percezione olfattiva
Solo una parte delle sostanze volatili può innescare una risposta olfattiva—devono essere sufficientemente leggere da vaporizzarsi e raggiungere la nostra cavità nasale, solubili nel muco che ricopre i recettori e possedere una forma molecolare compatibile con almeno uno dei nostri recettori olfattivi. Si stima che gli esseri umani siano in grado di distinguere tra migliaia di odori differenti, grazie alla combinazione di oltre un migliaio di tipi distinti di recettori olfattivi. Ogni odore è il risultato di una miscela di molecole che attiva diversi recettori in un preciso schema, un po’ come fare una combinazione su una cassaforte: lo schema di recettori attivati costituisce la “firma olfattiva” dell’odore.
- La qualità dell’odore dipende dal tipo di recettori attivati.
- L’intensità deriva dalla concentrazione delle molecole.
- La soglia olfattiva varia da persona a persona, influenzata da genetica ed esperienza.
A livello molecolare, le sostanze riconosciute come odori sono spesso molecole piccole e organiche: aldeidi, chetoni, alcoli, esteri e molte altre. Il nostro cervello è in grado di associare diversi schemi di attivazione a sensazioni olfattive distinte, riconoscendo anche leggere variazioni nella struttura delle molecole.
Curiosità e limiti dell’olfatto umano
Il senso dell’olfatto negli esseri umani è meno sviluppato rispetto a molte altre specie animali, ma mantiene capacità straordinariamente raffinate. Ad esempio, i neuroni olfattivi si rigenerano regolarmente: sono tra le rarissime cellule nervose del nostro organismo a farlo, consentendo un certo grado di recupero della funzione anche dopo danni o infezioni. C’è però un limite sulla durata della memoria olfattiva: spesso riconosciamo un odore già sentito ma fatichiamo a ricordare dove o come lo abbiamo incontrato.
Le percezioni olfattive possono essere influenzate da fattori genetici, età, stato di salute (alcune malattie, come l’influenza o il Covid-19, possono temporaneamente compromettere l’olfatto). Anche l’adattamento sensoriale gioca un ruolo importante: dopo qualche minuto di esposizione a un odore intenso tendiamo a non percepirlo più, poiché il sistema sensoriale si “adatta” concentrandosi su eventuali nuovi stimoli.
Inoltre, l’olfatto umano si combina e si sovrappone con altri sensi. Molti aromi alimentari, per esempio, vengono persi del tutto quando si ha il raffreddore, perché le molecole odorose non raggiungono l’epitelio olfattivo e di conseguenza l’esperienza del gusto risulta impoverita.
Negli ultimi anni, la ricerca scientifica sta continuando a svelare i misteri delle nostre percezioni olfattive, proponendo nuove teorie su come il cervello elabori il vastissimo panorama di odori che incontriamo ogni giorno e sul motivo evolutivo dietro il legame tra olfatto, emozioni e memoria. La complessità di questo sistema ne fa un campo di indagine ancora aperto, con possibili implicazioni future nella medicina e nelle neuroscienze.